ASTRI NASCENTI, STELLE CADENTI, MINE VAGANTI (1a parte)
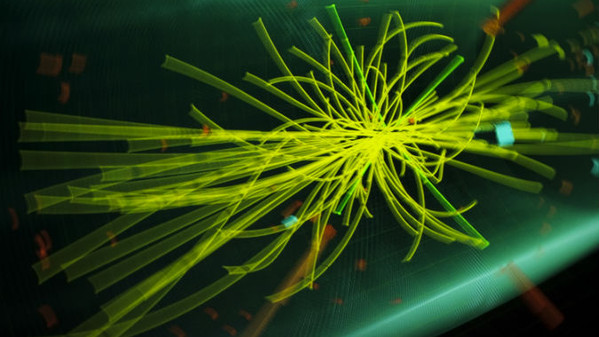
C’è comunque qualcosa di primordiale e prodigioso nella misera schizofrenia degli ultimi gesti del Cavaliere.
Kronos, padre di Zeus e dell’intero Olimpo, tutti figure rese terribili dalla loro sintesi di debolezze umane e potenza divina, usava divorare i propri figli per timore di perdere la propria supremazia.
Berlusconi, incapace di assimilare i propri figliocci, con la sua debolezza riesce ad andare oltre; per sopravvivere divora se stesso.
Già la dieta incestuosa del preolimpico doveva rivelarsi inadeguata alla bisogna sino a spingerlo nella profondità del Tartaro; figuriamoci l’esito segnato dell’autofagìa del Cavaliere. Sussulto dopo sussulto, invettiva dopo invettiva alla fine non fa che alimentare il disegno dei propri rivali del palcoscenico politico, feroci e rabbiosi perché incapaci di sconfiggerlo sul proscenio sino al punto di fargli crollare il palco da sotto i piedi pur di annientarlo. Ad ogni suo atto di accusa segue la sempre più repentina smentita di se stesso e una mano tesa verso gli artigli dei rivali; così facendo, ad ogni rinuncia corrisponde la dissolvenza di una parte della sua fisicità di uomo politico. Di questo passo Berlusconi continuerà a presenziare anche da reietto e estromesso dai luoghi della politica; sempre meno come decisore effettivo, sempre più come ectoplasma il quale, per esprimersi, avrà bisogno dei medium e di un tavolo spiritico. I teatranti, sia i sostenitori che gli avversari, avranno ancora bisogno di lui perché incapaci di assumere ruoli da protagonisti e di scrivere nuove scenografie; per qualche tempo, dopo averlo perseguitato per decenni, lo zavorreranno impietosamente e impediranno al suo spirito di allontanarsi dalle miserie terrene in cerca del gaudio libertino.
Una condizione legata in parte alla forza degli eventi, ma soprattutto al fatto che tutti, sia il Cavaliere, che i comprimari, che le comparse sono suggestionati da un unico burattinaio, per quanto appostato lontano sull’altra sponda dell’oceano. L’unico parziale atto di coraggio che il Cavaliere si è concesso nei tempi recenti è qualche invettiva ai gabellieri teutonici e transalpini intenti a scremare una parte del bottino ma solo per legarsi ancor più all’uomo nero; per il resto, una guerricciola di posizione con continui arretramenti sino all’attuale ultimo ridotto.
Le immagini offerte dalla seduta del Senato del 2 ottobre, culminate con la fiducia al Governo Letta, sono di una grottesca crudeltà.
Letta e Alfano fianco a fianco che si scambiano sorprendentemente pacche e sorrisi complici e sollevati ancor prima del voto; Berlusconi con le gote gonfiate dai singulti incontrollati dopo il suo “j’accuse” trasformatosi inopinatamente in un atto di fiducia all’allegra compagnia; Alfano che per un attimo si accorge del tormento del maestro tradito e lo fissa corrucciato, lo sguardo interessato di un bue al passaggio di un treno.
Le labbra e le braccia del Cavaliere sembravano costrette da una forza superiore opposta alla sua volontà; recitavano la propria condanna anche se lasciavano al colpevole un piccolo margine di scelta sulle modalità di esecuzione della sentenza.
Berlusconi aveva solo due possibilità; portare lo scontro alle sue estreme conseguenze o assecondare gli eventi partecipando al gioco della sua fine.
Come al solito ha scelto la seconda.
In ritardo, nei modi e nel momento sbagliato, aveva chiesto la sfiducia al Governo per poi riconcederla una volta constatata la parziale dissoluzione delle proprie truppe; non sappiamo per altro quali tipi di pressione deve aver subito in quelle ore.
Non so quanto questi passi contraddittori fossero almeno in parte preordinati o quantomeno indotti per consentire l’adozione automatica di misure altrimenti pubblicamente osteggiate (aumento dell’IVA) e soprattutto l’accelerazione della transizione innescata dal Governo Letta. Qualche sospetto rimane.
Si è trattato di uno di quei rari momenti in cui il dilemma personale corrisponde effettivamente a due direzioni possibili da imprimere alle vicende politiche.
La prima, legata alla sfiducia, avrebbe provocato una diaspora incontrollata dal PDL con la ennesima creazione di forze satellitari attorno al PD, determinanti in Parlamento, ma senza radicamento reale; avrebbe consentito, però, la salvaguardia dello zoccolo duro del partito e, quantomeno, determinato una maggiore difficoltà a proseguire nelle ambiguità in politica estera e sulla Unione Europea. Avrebbe comportato una drastica e traumatica accelerazione della caduta in disgrazia di Berlusconi ma anche la cesura del cordone ombelicale che assoggettava a lui gran parte dei dirigenti superstiti.
La seconda, sul solco delle scelte per lo meno degli ultimi quattro anni, lascia al PDL qualche possibilità di assumere la leadership del partito trasformista in via di formazione a danno della propria componente radicale condannata alla frammentazione o ad un ruolo puramente collaterale.
Pur con la stizza manifestata da chi nel PD già pregustava, ancora una volta, la divisione del gruppo parlamentare berlusconiano e da Monti stesso il quale, come da lui preannunciato in tarda primavera, confidava ingenuamente di attendere pazientemente la raccolta dei cocci di un PDL in dissolvenza, mi pare che la seconda opzione fosse a denti stretti la più gradita dall’establishment e assecondata, obtorto collo, dal cavaliere.
La fragilità dell’attuale oligarchia al comando, di fatti, non consente di reggere la pur minima critica da parte di élites rivali, per non dire alternative. Basterebbe osservare come hanno fulminato la minima licenza critica di Renzi, nella sua campagna per l’elezione a segretario del PD. Berlusconi, dal canto suo, pare ancora in grado di mantenere l’unità dell’area, anche se non del partito e di ricondurla, volente o nolente, a questo progetto trasformistico; tanta arroganza tutt’al più consente ai dissenzienti reali di relegarsi nel limbo sterile dell’astensionismo. La considerazione di Cicchitto di giungere, in ultima istanza, alla creazione di due partiti federati, uno istituzionale l’altro movimentista, sotto il nome e l’egida di Berlusconi, rappresenta l’apoteosi cervellotica di questo processo. Vedremo sino a che punto il “popolo” si lascerà manipolare da questa realizzazione.
L’unica certezza è che le spoglie e le ricchezze finiranno in pasto, ma lo spirito di Berlusconi continuerà ad aleggiare per diverso tempo con sollievo di detrattori e fautori; più, però, asseconderà il progetto, meno tracce degne di rilievo lascerà però nella storia.
Che l’evaporazione sia ormai prossima, lo dimostra l’accelerazione del ritmo delle fibrillazioni e dei ripensamenti. Berlusconi vorrebbe assumere, come ultima spiaggia, nel suo partito il ruolo che Beppe Grillo, dall’esterno, assume verso il movimento 5stelle. Dalla sua ha ancora il residuo richiamo elettorale e la detenzione assoluta delle risorse economiche ed organizzative dell’ex-PDL, risorse ancora sufficienti per tenere a bada in qualche maniera i partiti avversi e le fazioni interne; poca cosa, però, rispetto alla soverchiante capacità dirompente, ormai senza freni, dell’apparato giudiziario e di altri settori dello Stato a lui avversi i quali presumibilmente, troveranno ulteriore alimento dalla rifondazione del partito.
A questo punto occorre osservare da vicino i tre attori principali sul palcoscenico, il Governo Letta – il PD – il PDL e i coprotagonisti, per quanto questi ultimi già appannati, che fungono da corollario, prigionieri di un ruolo e di eventi dei quali a tratti sembrano coscienti di aver perso il controllo.
IL PD
Da tempo il Partito Democratico riesce a far convivere una residua solidità e capillarità organizzativa, esempio unico ormai nel paese, con la propria paralisi politica.
Almeno a partire dagli ultimi tre anni, l’intero gruppo dirigente del PD ha fondato la propria politica su tre pilastri: la vittoria della sinistra in Europa nelle varie elezioni nazionali; la ricostruzione conseguente di una solidarietà europea e di una politica comunitaria fondata sulla parità degli stati e sulla cessione di sovranità ad istituzioni europee sino ad arrivare alla federazione europea; una conversione radicale di segno solidaristico della politica comunitaria tedesca. Più che pilastri, in realtà, a ben vedere i puntelli esterni di una costruzione politica nazionale priva di luce propria.
Una ad una, le aspettative di quei puntelli sono venute meno miseramente.
La grande ondata socialdemocratica che avrebbe dovuto sommergere l’intera Europa ha lambito a malapena le coste francesi, si è impantanata nel Belpaese, è naufragata clamorosamente in Germania.
Quanto al solidarismo europeo della famiglia socialista, ci hanno pensato i socialdemocratici tedeschi a soffocare definitivamente l’afflato elettoralistico comunitario grazie al loro scambio casereccio, pattuito con la Merkel, del riconoscimento di un salario minimo orario nazionale con la rinuncia ad una politica keynesiana europea, concordata nei mesi passati con gli altri partiti socialisti europei, fondata sugli eurobond, sulle garanzie tedesche sul debito europeo e su una espansione significativa degli investimenti europei e della domanda interna tedesca; un afflato, per altro, reso vacuo già dall’accettazione repentina da parte di Hollande di quelle politiche europee così duramente criticate in campagna elettorale, dello stesso precedente sodalizio franco-tedesco, salvo ritagliarsi qualche beffarda trasgressione unilaterale sul deficit pubblico, tollerata benevolmente dal dirimpettaio tedesco. Il terreno più congeniale su cui le sinistre europee hanno riscoperto la migliore affinità è alla fine quello del cieco allineamento, pur con qualche distinguo tedesco, all’avventurismo americano. Li abbiamo visti all’opera in Libia e Siria, addirittura più oltranzisti e baldanzosi del re; in maniera più subdola nei rinnovati propositi di “allargamento concentrico” dell’Unione Europea all’Ucraina, alla Moldova, alla Lituania, alla Georgia, all’Azerbaijan in funzione dichiaratamente antirussa; ammantati della retorica egualitaria europeista quando, dietro la rivendicazione velleitaria di pari dignità di tutti gli stati europei e dietro il potenziamento e la legittimazione della Commissione Europea, in realtà non fanno che confermare e sostenere il ruolo di deus ex-machina degli Stati Uniti nella attuale costruzione europea, in perfetta continuità con la politica scaturita dall’esito della seconda guerra mondiale. Il vero contenzioso in atto tra le ex potenze europee risiede nella conquista del posto migliore nelle gerarchie inferiori della corte atlantica. Il documento concordato dalla futura coalizione tedesca, nella sua ambiguità, rappresenta ad esempio nella fattispecie una vera e propria sfida ai “fratelli” europei addirittura in aree, il Mediterraneo, dove francesi, inglesi ed italiani potevano sfruttare ancora il retaggio del loro passato recente, resa praticabile soprattutto dalla neutralità formale più che effettiva nelle vicende libiche e siriane.
Una parzialissima ma significativa contabilità dei costi economici di tanto italico sussieguo, al contrario, ce la offre Lapo Pistelli, viceministro e responsabile esteri del PD ( http://video.repubblica.it/rubriche/rnews/rnews-l-iran-tratta-a-ginevra-pistelli-perche-all-italia-conviene/143083/141618?ref=search ); i costi politici del totale appiattimento si possono intravedere invece nelle ingenue aspettative del cortigiano d’occasione.
Un gruppo dirigente che fonda le proprie aspettative di successo sul buon cuore di istituzioni sovranazionali e sul solidarismo comunitario in una fase in cui quelle stesse istituzioni sono solo uno dei terreni di confronto e conflitto di interessi e strategie nazionali e interne alle nazioni stesse nel migliore dei casi conduce il proprio paese all’impotenza, nel peggiore all’asservimento consapevole.
Un gruppo dirigente il quale, per quanto diviso, classifica unanimemente quelle politiche secondo un mero criterio di correttezza, come giuste o sbagliate, oppure egoistiche o solidali non fa che spargere nebbia sulla reale composizione degli schieramenti e sulle finalità delle diverse strategie.
L’attuale dibattito congressuale del PD rappresenta l’apoteosi di questa condizione. L’assenza di programmi politici dichiarati consentono vie di fuga esistenziali con l’ambizione dichiarata addirittura di modificare la condizione ultima dell’uomo.
Ecco un piccolo florilegio di citazioni tratto dai documenti congressuali e di sostegno ai vari candidati.
Così Goffredo Bettini, leader della sinistra del sentimento che spazia dagli imprenditori illuminati a Niki Vendola e artefice della elezione di Marino a sindaco di Roma “La partecipazione, nel Pd, deve essere un atto-tentativo di liberazione e di emancipazione della persona: dalle gabbie del luogo comune, per quello che è possibile dall’angoscia dell’esistenza, dalla fragilità della nostra natura individuale oggi più che mai esposta” (http://www.europaquotidiano.it/2013/07/09/un-nuovo-campo-democratico/ ). Prosegue Alfredo Reichlin il quale dice “Lo sfruttamento è ben altra cosa (dal rapporto capitale/lavoro): riguarda il lavoro ma investe tutta la condizione umana: la vita, i modi di pensare, i territori”; quindi “Un nuovo umanesimo: questo mi sembra il messaggio che dovrebbe dare il Congresso del P.D” (http://www.unita.it/polopoly_fs/1.508015.1372315872!/menu/standard/file/notecongresso19giugno.pdf) Per finire con Cuperlo: “bisognerà fare perno su termini come reciprocità e gratuità, in una logica dove non esista solo il “dare per avere” o il “dare per dovere”. Le nostre società vedono l’emergere di nuovi bisogni quasi ogni giorno. Il vecchio intervento pubblico non può farvi fronte da solo. Non è tanto questione di costi o risorse insufficienti, che pure pesano. È la presa d’atto dell’esistenza di una domanda di beni relazionali come l’amicizia o la fiducia.”
La diretta conseguenza è che, piuttosto che ad un confronto di idee e di proposte, a dei tentativi di analisi concrete, assistiamo a sermoni tesi ad ispirare le platee residue e fidelizzare i partigiani.
Cuperlo è l’antesignano di questo stile; Renzi è l’unico a sfuggire all’impeto messianico, ma solo per aver scelto una narrazione più opportunistica, pronta a cogliere l’umore del momento, apparentemente disposta a cogliere i contributi e a favorire la partecipazione dal basso; il canovaccio studiato dal suo staff di prim’ordine, ispirato alle campagne presidenziali democratiche americane e impostato concretamente da alcuni di quegli artefici, è apparentemente partecipativo, in realtà rigidissimo, tutto improntato all’ottimismo delle opportunità da cogliere.
Eppure, pur nella inedita fumosità, quei documenti qualcosa lasciano trapelare riguardo ai punti di vista e alle intenzioni dei gruppi dirigenti e alla propensione al malinconico declino cui stanno condannando il paese.
IL GRANDE NARRATORE
Cominciamo dall’outsider ormai in predicato di assurgere all’incarico di segretario del PD. Dalla sconfitta alle primarie nel 2012 alla resurrezione legata all’esito elettorale deludente del PD, Renzi si è assunto un ruolo alquanto improbo e ambiguo; riuscire a conservare, almeno in un primo momento, lo zoccolo duro dell’elettorato democratico e conquistare, contestualmente, l’elettorato in fuga da Berlusconi e dal M5S di Grillo.
Una acrobazia temeraria anche per un funambolo della parola, con probabilità di successo rese ancora più risicate dalla presenza di avversari dentro e fuori il partito in crisi endemica, ma ancora sufficientemente radicati nello zoccolo duro rispettivo e pronti, quindi, ad agitare lo spauracchio degli interessi particolaristici fine a se stessi.
Il recente assalto, subito nella tana di Santoro, giovedì 7, ha infatti visibilmente disorientato l’ambizioso rampollo. http://www.serviziopubblico.it/puntate/2013/11/08/news/leader_adesso.html?cat_id=10
I due documenti sino ad ora apparsi a sostegno, quello ufficioso dell’economista Gutgeld http://noidemsa.files.wordpress.com/2013/06/il-rilancio-parte-a-sinistra.pdf e quello di presentazione ufficiale della candidatura http://www.partitodemocratico.it/speciale/congresso2013/documenti/doc_congressuale_renzi.pdf non tracciano un programma politico coerente. I motivi tattici sono quelli appena citati e sono dettati dalla necessità di sfuggire quanto più possibile agli attacchi. La riprova è l’inattesa e reiterata insistenza sul carattere di sinistra delle proposte
Le ragioni di tanto eclettismo sono però più profonde.
Alcune affermazioni ed alcuni vuoti clamorosi riescono comunque a delineare i caratteri essenziali di questa “nouvelle vague”. Ecco i più salienti: “Italia ce la può fare perché abbiamo imprenditori straordinari e lavoratori capacissimi” “Italia ce la può fare perché i nostri problemi nascono da una cattiva gestione del bene pubblico” “La soluzione si trova a sinistra perché passa inevitabilmente attraverso la comprensione e la denuncia della profonda iniquità sociale che la cattiva gestione ha prodotto”; “L’Italia è il paese delle gilde e delle associazioni” in contrapposizione alla “maggioranza silente” de “i cittadini, in particolare quelli onesti e poveri” tutelabili solo dalla sinistra; la prospettiva è coltivare “i settori strategici del turismo e dell’agroalimentare”. Lo strumento politico del rilancio deve quindi essere “il PD come partito di amministratori, circoli e parlamentari”.
Depurate dalla inevitabile retorica di una contrapposizione nuovista ad una classe dirigente ormai sclerotizzata, sono espressione di una visione che condannerà l’Italia a ulteriori smarrimenti e ad un ulteriore declino e subordinazione, questa volta conditi di ottimismo giovanilista piuttosto che della malinconia di un Bersani; un compendio di affermazioni fuorvianti. Siamo alla contrapposizione, ancora una volta, di stampo liberale tra una società civile idealizzata, virtuosa, dinamica e competente e i cattivi gestori del bene pubblico. Una contrapposizione già rappresentata con successo dal primo Berlusconi e, sotto altre sembianze, da Grillo. Un discrimine che non riesce a spiegare la nascita e lo sviluppo dell’attuale componente più dinamica dell’imprenditoria privata, frutto, in realtà, di precise scelte politiche avviate sul finire degli anni ’70; tanto meno riesce a comprenderne i grossi limiti strategici e le evidenti carenze organizzative di parecchi tra questi settori e gruppi, evidenziati, per altro, ormai da anni anche da studiosi liberali appena più seri del novello “enfant prodige”; ancora, una simile chiave interpretativa non consente di individuare la composizione pubblica/privata dei vari centri decisionali e delle relative cordate in conflitto e cooperazione tra di essi e ben relazionate e subordinate, tra l’altro, all’estero. Come spiegare, altrimenti, il connubio attivo tra il privato Valletta (Fiat), altri industriali rampanti dell’epoca e settori istituzionali e politici nello stroncare le possibilità di sviluppo dell’informatica dei grandi elaboratori dell’Olivetti negli anni ’60; così come la cosciente interdizione da parte dell’allora amministratore di Olivetti, il rampante privatissimo De Benedetti, di ogni collaborazione con la pubblica IRI-Stet tesa a integrare la rete telematica ed il computer qualche lustro prima che ci arrivassero gli americani; ed ancora il nesso tra le dismissioni dell’industria pubblica strategica e complementare negli anni ‘80/’90, la perdita del controllo della rete commerciale nazionale, la stagnazione e crisi infine della piccola e media industria. L’idea che l’attuale condizione del paese sia il risultato dei limiti socioeconomici e quindi, anche civili, del paese ma soprattutto la conseguenza di scelte politiche disastrose e grette, chissà in quale recondita parte del cervello di Renzi sarà annidata, ammesso che esista. Ammantata di globalismo, mondialismo, cosmopolitismo non riesce a individuare la morsa sempre più stringente che dagli anni ’90 ha attanagliato un paese sempre più frammentato, con un ceto politico e decisionale polverizzato e rissoso che si è lasciato sorprendere, inerme in alcuni e complice in altri, senza nemmeno comprendere, in gran parte, la reale dimensione degli eventi. Basterebbe, in proposito, citare l’episodio della nomina di Nino Galloni, notoriamente contrario alle privatizzazioni, a direttore delle politiche di bilancio e della sua repentina retrocessione da parte di un politico avveduto come Andreotti, per intuire il disorientamento dell’epoca. Quelle scelte, culminate con l’allargamento dell’Unione Europea e della NATO, l’introduzione dell’euro, i tentativi di dissoluzione della Russia, furono assecondate tranquillamente anche dalla maggior parte di quegli imprenditori “capaci e straordinari”, in particolare lombardo-veneti, i quali tifavano apertamente per una integrazione con la Baviera nel mentre la Germania era impegnata a crearsi una area di integrazione economica in Europa Orientale alternativa a quella italo-tedesca; oppure pontificavano, valigetta alla mano, sulle meraviglie di quel mercato globale a disposizione dei più intraprendenti nel mentre gli stati più potenti o quantomeno accorti erano impegnati a regolare i mercati secondo le strategie politiche e le convenienze economiche proprie. Le conseguenze economiche, in particolare per le imprese italiane e per i dipendenti e gli operatori, delle chiusure politiche verso la Russia e l’Iran, di destabilizzazione distruttiva di numerosi stati nordafricani e mediorientali, delle scelte particolari di integrazione europea e di regolazione dei suoi mercati nazionali, della loro subordinazione rispetto agli interessi geopolitici, sono ormai evidenti e dolorose.
Sono un indizio che lascia intendere che i manager e i proprietari delle grandi imprese, comprese quelle finanziarie, i responsabili delle associazioni degli imprenditori minori, i capitalisti quindi, fanno parte certamente dei centri strategici e decisionali, ma raramente ne sono la componente determinante; piuttosto tendono ad aderire, ad adeguarsi e a cogliere le opportunità o limitare i danni delle scelte determinate soprattutto da altri livelli comunque radicati nelle formazioni sociali e negli stati nazionali, quantomeno quelli dominanti e con livelli accettabili di sovranità.
Un aspetto disconosciuto curiosamente sia dai mondialisti, dai globalisti e dagli antiglobalisti fautori del predominio dei centri di potere sovranazionali, specie finanziari, che dai liberali; sia dai fautori del centro unico di comando che da quelli di una società atomizzata e individualizzata.
Un disconoscimento operato coerentemente anche da Renzi, dalle grandi ambizioni ma ancora un piccolo semplice meccanismo di questo ingranaggio.
Una impostazione che ha poco da offrire al paese se non l’esaltazione retorica della creatività italiana. Gli esempi esibiti nella sua kermesse fiorentina, alla Leopolda, non vanno oltre l’agroalimentare (Farinetti) e i pochi marchi superstiti dell’italian fashion, settori di nicchia importanti, ma complementari in un programma di rinascita del paese. È una retorica che, per altro, nulla dice sull’incapacità ricorrente di creare e mantenere solide piattaforme industriali a sostegno di questa creatività, specie nei settori strategici.
Il controllo delle attività, la costruzione di rapporti equilibrati se non paritetici tra aziende di diversa provenienza nazionale non sono assolutamente un problema per il politico; tutt’al più lo si riduce ad una forma di tifoseria puramente emotiva. I capitali, a suo dire, non hanno passaporto. La globalizzazione è una opportunità da cogliere che sta comunque consentendo ai paesi più intraprendenti di emergere e di sollevarsi anche dalla povertà.
Alla fine, le strozzature, le iniquità sociali, la corruzione, la disonestà si alimentano, nel nostro paese, della “cattiva gestione”, secondo l’aspirante segretario. Ancora una volta si tende a ricondurre, a subordinare la soluzione di questi problemi alla capacità e al merito, ad una questione “tecnica”. In effetti, il paese soffre sempre più del problema della selezione e del riconoscimento delle competenze, soprattutto nel settore della pubblica amministrazione, ma anche nelle grandi aziende di servizi e nelle stesse attività industriali; la definizione e il riconoscimento di queste ultime, però, sono in funzione della gestione dei conflitti e della cooperazione dei gruppi nella formazione sociale e nel sistema produttivo e degli obbiettivi e delle ambizioni dei gruppi dirigenti del paese; classi dirigenti che non si pongono il problema e l’ambizione realistica di costruire una collocazione autorevole e autonoma di un paese arrivano presto o tardi ad una logica di difesa corporativa e retriva dei propri interessi e a processi sterili di fidelizzazione di tipo clanico. Piuttosto che esplicitare scelte di fondo che si guarda bene da contestare e del quale è portatore cosciente, Renzi ripropone l’antitesi tra la funzione negativa di “gilde e associazioni” e quella positiva e romantica della “maggioranza silente” dei singoli cittadini onesti, poveri e competenti; non a caso il nostro, da politico ambizioso di paese di periferia, accomuna negli strali la gilda all’associazione e glissa sul fatto che tutti i paesi e gli stati, specie i più organizzati e influenti, operano sulla base di gruppi più o meno strutturati e riconosciuti sino a riconoscerne esplicitamente le funzioni, come avviene ad esempio negli Stati Uniti, patria eletta del liberalismo, e in Germania.
La visione organizzativa che Renzi offre del “suo” futuro Partito Democratico è una conseguenza indiretta di questa impostazione. “Il PD come partito di amministratori, circoli e parlamentari” mira aduna struttura apparentemente priva dei legami con le strutture verticali che sostengono e possono garantire una qualche coerenza del paese (sindacati, associazioni professionali, centri di potere). La solidità di uno stato federale e decentrato come quello tedesco si fonda, infatti, sulla solidità e coesione politica di questi centri. Il nostro riformatore, al contrario, perseguendo l’obbiettivo di dissestare definitivamente il nucleo dirigente storico del partito, in realtà, con il suo apparente democraticismo dal basso, non fa che assecondare nell’ambito del partito quello stesso processo di disarticolazione in atto nel paese e il localismo di gruppi; vede nelle città il fulcro della crescita sociale e politica del paese; in realtà alimenta il terreno ideale per far prosperare oligarchie facilmente etero dirette e poco preoccupate e capaci della costruzione di solidi blocchi sociali, galleggianti su un paese frammentato. Una propensione che Renzi ha già dimostrato di voler coltivare con certosina ostinazione e discrezione.
In questo contesto, proclami fondati da oltre due secoli su eguaglianza, equità, lotta alla povertà, redistribuzione stanno seguendo lo stesso percorso, velleitario nel migliore dei casi, retrivo e mistificatorio nella concretezza delle scelte politiche, seguito dal vessillo dei diritti umani e dell’emancipazione di gruppi particolari (femminismo, libertà religiosa, omosessuali, ect). Un percorso che sta accomunando sempre più Renzi ai suoi contendenti, man mano che il suo impegno è sempre più rivolto, per il momento, al recupero dello zoccolo duro del partito piuttosto che a sconfinare nelle praterie berlusconiane. L’enfasi che le sue tesi dedicano ai problemi della scuola e della sanità, residue roccaforti elettorali democratiche, sono rivelatorie di questa preoccupazione.
